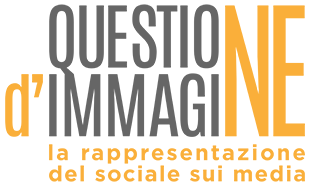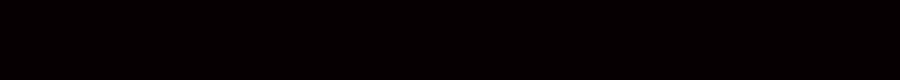di Raffaella Cosentino
Mare Nostrum. La narrazione mediatica dei cosiddetti ‘sbarchi’ è stata, secondo molte ricerche e osservatori, il modo prevalente con cui sono stati comunicati agli italiani i flussi migratori. L’operazione “Mare Nostrum”, lanciata dal governo italiano dopo la strage del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, segna un momento particolare all’interno di questo racconto. Si tratta della più grande operazione di salvataggio in mare mai fatta. Attraverso l’impiego di una flotta di navi della Marina Militare, riconvertite per un uso umanitario, e coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma che raccoglieva gli Sos dai barconi in difficoltà, sono state salvate dai naufragi circa 170 mila persone, l’equivalente di una città medio – grande. L’operazione è stata condotta per un periodo di tempo di circa un anno a partire dalla fine del 2013. Negli ultimi mesi del 2014 Mare Nostrum è stata chiusa dal governo italiano per i suoi costi molto alti e sostituita dalla missione europea Triton, coordinata da Frontex, l’agenzia europea delle frontiere. Triton ha ristretto il raggio d’azione in mare e ha come suo scopo prevalente la salvaguardia delle frontiere marittime dell’Ue, non il salvataggio di vite umane.
Gli sbarchi nell’immaginario collettivo sono l’emblema delle migrazioni irregolari. Ma in realtà sono pochissimi gli sbarchi “orfani”, termine che indica la situazione in cui un’imbarcazione di migranti arriva da sola in porto o sulle coste. Quelli che tutti chiamano ‘sbarchi’ sono sempre state operazioni Sar (Search and Rescue), in cui i migranti venivano salvati da naufragi in alto mare, spesso ancora in acque internazionali, e trasportati a riva su motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Trattandosi di operazioni di soccorso in mare, ecco spiegato anche il motivo per cui tutti gli arrivi si sono concentrati per anni sull’isola di Lampedusa e non anche su Pantelleria o Linosa. Nel caso di Mare Nostrum, essendo le navi più grandi delle classiche motovedette, i migranti sono stati sbarcati nei porti della Sicilia, come Augusta, Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Catania e Palermo. Per questo, per tutto il periodo di attività di Mare Nostrum, Lampedusa è uscita dalle rotte migratorie e non ha ospitato migranti se non in rare occasioni.Nel contesto dell’immigrazione, gli eventi Sar si riferiscono prevalentemente a ciò che accade nel Canale di Sicilia durante i flussi migratori dal Nord Africa.
I salvataggi sono previsti da tutti i trattati internazionali e corrispondono alla ‘legge del mare’ secondo la quale bisogna sempre dare la precedenza alla tutela delle vite umane.
L’elemento del “salvataggio” emerge con forza con Mare Nostrum. L’operazione della Marina militare ha la potenza di spostare il focus dai migranti “sbarcati” a quelli “salvati”.
La scelta delle autorità è stata quella di autorizzare l’accesso a bordo delle navi di un numero limitato di fotografi e di troupe “embedded”. Il racconto che ne viene fuori è un’epopea dei salvatori. Il settimanale Io Donna del 10 maggio 2014 presenta un reportage realizzato con la Fondazione Rava.
La fotografia in copertina si discosta parzialmente dall’iconografia classica dei barconi. Vediamo infatti i migranti seduti in maniera ordinata e tutti dotati di un giubbotto di salvataggio. Da questo si capisce che è in corso un’operazione di soccorso. Il titolo, “Il vostro sorriso è la nostra forza” sposta l’attenzione dai migranti a chi li aiuta. Come spiega bene anche il sommario al di sotto: “si sono messi al servizio degli ultimi, ma sentono di aver ricevuto più di quando hanno dato”. Si sta parlando dei soccorritori italiani imbarcati con Mare Nostrum.

Anche la cornice di riferimento cambia. Non più l’emergenza immigrati abituale per i media, bensì l’emergenza Mediterraneo. Il racconto si sposta in mezzo al mare. L’elemento nuovo e attrattivo per i media è che con Mare Nostrum si può assistere direttamente al momento del salvataggio delle vite umane a molte miglia di navigazione dalla terraferma.
“Quando li recuperano in mare, centinaia di migranti eritrei, siriani, nigeriani, donne e bambini stipati in barconi fatiscenti, quello che importa è tenerli calmi perché il natante non si rovesci proprio all’ultimo, a poche miglia dalla salvezza. La parola magica è “italiani”. Vuole dire: non siamo aguzzini, siamo qui per aiutarvi, vi porteremo a bordo della nave e poi a terra”.


Con gli occhi dei soccorritori. Questo reportage riassume quella che è la narrazione prevalente dell’operazione Mare Nostrum, in cui i veri protagonisti non sono mai i migranti, bensì i soccorritori. Il coraggio di cui si parla non appartiene quasi mai a chi si affida a trafficanti di uomini, affronta insidie di ogni genere e viaggi pericolosi per sottrarre un bimbo alle bombe di una guerra, ma è quello di chi trae in salvo i profughi. I migranti restano sullo sfondo. Infatti, a parte la questione del soccorso marittimo, l’occhio dei media con Mare Nostrum tende a riproporre un modello classico sui boat people. Li si vede ammassati sulle barche o sulle navi, li si conta con numeri via via esponenziali. Le navi della Marina effettuano numerose operazioni di soccorso prima di fare rotta verso la Sicilia e sbarcare i migranti, che così si trovano a essere in centinaia e centinaia a bordo.
Conseguentemente l’effetto numerico viene amplificato dalle immagini del ponte delle navi carico di profughi. Vengono presentati in perenne attesa. In fila, seduti, scomposti. In attesa di essere salvati, in attesa di essere sbarcati, in attesa di essere accolti e di ricevere un tozzo di pane. È frequente vederli nell’atto di tendere le mani ai soccorritori o di prendere un sacchetto di cibo.
“Trentamila esseri umani in fuga da guerre e fame salvati in sei mesi (e, stima il Viminale, 800 mila in arrivo nei prossimi mesi). Una catastrofe umanitaria sventata insieme al rischio che il Mare Mediterraneo diventasse la più grande fossa comune del pianeta: questo il bilancio della missione Mare Nostrum, condotta dalla Marina Militare Italiana che vi ha impegnato gran parte delle proprie risorse. Un miracolo di coraggio, generosità e talento nell’accogliere, nella sostanziale indifferenza del resto d’Europa e nonostante il fatto che, una volta a terra, il meccanismo si inceppi e i migranti non trovino facilmente il tetto e il pane di cui sono in cerca. Sono vivi, però”. Io Donna 10 maggio 2014

Il punto di vista resta quello dei soccorritori con l’enfasi sul piano umano. Qui vediamo che vengono raccontate le loro storie, con quattro diversi profili. Il medico anestesista, la volontaria, l’ostetrica. “Il valore di queste esperienze è l’uomo a 360 gradi. Non sei lì solo come medico. Davvero non sarebbe possibile” dice uno di loro nell’intervista.


Negli ultimi anni la narrazione si fa epocale. In un rapporto del 2012 realizzato per Medici senza Frontiere, i ricercatori dell’Osservatorio di Pavia hanno sottolineato che, sugli sbarchi, “l’ampia visibilità è stata poco accompagnata da una dimensione esplicativa del fenomeno ed è stata spesso caratterizzata dal primato della comunicazione emotiva su quella informativa-razionale”. Gli elementi principali di questo tipo di racconto, che raggiunge il culmine con i servizi televisivi, sono stati: la prevalenza della cronaca e del dibattito politico sull’approfondimento, uno sguardo sugli effetti immediati più che sulle cause, un utilizzo di toni allarmistici, un lessico epocale ornato di da metafore naturali e belliche, una certa poetica del patema nel racconto, una dimensione geografica del problema essenzialmente italiana, la mancanza di voce degli operatori che hanno gestito la crisi e dei migranti. Secondo questa analisi, i migranti, che sono all’origine della notizia, hanno avuto un tempo di parola pari al 14%, mentre i politici (locali e nazionali) hanno avuto il 65%.