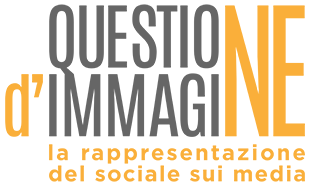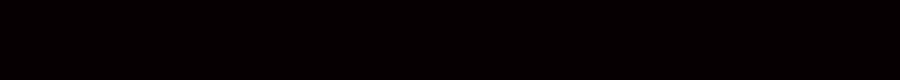di Andrea Pogliano
L’evocazione di immagini attraverso il narrato televisivo e le parole. Prima di guardare al caso dello “stupro della Caffarella” in maniera dettagliata, analizzando telegiornali e articoli di giornale con particolare attenzione alle immagini e all’immaginario, spendiamo qualche parola sul complesso rapporto tra crimine/violenze, immigrazione, visibilità e sospetto.
Innanzitutto va detto che la cronaca dei crimini può contare assai raramente su immagini significative. I telegiornali in questi casi si compongono in larga parte di sequenze di immagini ripetitive e ripetute (qualora la notizia venga ripresa per più giorni) di controlli delle forze dell’ordine, di macchine della polizia o dei carabinieri, di luoghi (strade, parchi) più o meno anonimi. L’immagine che spesso manca è proprio quella del reo, o addirittura del “mostro” da “sbattere in prima pagina”. Si crea così un vuoto d’immagine che va riempito in altri modi. E’ la narrazione a caricarsi sulle spalle questa attesa dell’elemento visivo.
Si produce allora un’evocazione di immagini attraverso il narrato televisivo e le parole del giornalismo a stampa. Per quanto riguarda le immagini, i media utilizzano delle immagini di repertorio e delle fotografie di stock per riempire questa attesa.
L’ambiguo rapporto tra immagini e testi. Come già notava Barthes (1977, Il messaggio fotografico), il rapporto tra immagini e testi è un rapporto ambiguo. Le immagini sono pensate come indici e come tracce, aventi un rapporto diretto e immediato con la realtà (il livello denotativo); al tempo stesso però le parole dicono, in molti casi, come interpretare le immagini. Sospese tra l’effetto di realtà e il simbolismo (il livello connotativo), le fotografie nell’informazione sviluppano questa ambiguità al massimo livello. Questo perché il registro retorico dell’informazione è quello dell’aderenza ai fatti.
Boltanski (1965), intervistando i fotografi di un quotidiano e quelli di un settimanale francese, distingueva tra le fotografie per i quotidiani e quelle per i settimanali. Le prime – sosteneva – sono legate a un’estetica dell’azione, del “qui e ora” (l’effetto realtà); le seconde sono spesso delle costruzioni simboliche che tengono dentro alcuni aspetti della realtà narrata ma la presentano all’interno di una codificazione più aperta (la connotazione).
Guardando al giornalismo italiano a stampa e televisivo, le immagini di repertorio hanno spesso un legame diretto con i fatti che si raccontano (aderenza dei luoghi, dei soggetti, delle azioni principali), ma in molti altri casi, questo legame è indiretto e arriva a livelli di astrazione molto alti.
L’immagine riempitiva e la generalizzazione del sospetto. L’immagine riempitiva diventa un meccanismo connotativo di generalizzazione del sospetto. Intorno al fenomeno immigrazione è poi andato consolidandosi una sorta di codice tacito delle immagini riempitive. In assenza di fotografie direttamente collegate con i fatti narrati, le immagini vengono scelte secondo criteri semplici di ricerca nei vasti archivi digitali per parole-chiave. I nessi immagini-parole che sono andati sviluppandosi negli archivi digitali meriterebbero di essere fatti oggetto di uno studio a sé, perché spesso rivelano il grado zero di consolidamento dello stereotipo.
A differenza dei quotidiani poi, i settimanali sono più spesso impegnati a raccontare dei temi piuttosto che degli eventi specifici. È lì che le immagini scelte per illustrare mostrano tutta la loro debolezza sul piano denotativo e tutta la loro forza sul piano connotativo.
Le immagini del controllo a un venditore abusivo di sigarette, qui sotto riprodotte attraverso alcuni impaginati mostrano bene il cortocircuito.
Come emerge dall’esempio, le stesse immagini di repertorio possono servire a connotare “i crimini commessi dagli extracomunitari” o quelli commessi da uno o più gruppi nazionali specifici, con gradi diversi di urgenza e preoccupazione. L’importante è che siano ben visibili le forze dell’ordine, che l’immagine rimandi all’immaginario generico del crimine. Al resto ci pensano le parole. In molti altri casi però le immagini promuovono dei significati che non sono contenuti nei testi scritti. Ciò che non viene detto, viene talvolta mostrato, costruendo una messaggio parallelo che può risultare rivelatore di un’implicita maniera di pensare e definire il tema in questione.
L’esempio seguente è quello di una immagine di stock usata da Panorama per illustrare un servizio generico sulla criminalità in Italia, che riporta i dati sui crimini e quelli di alcuni sondaggi sulla percezione dell’insicurezza. Qui la criminalità non riguarda solo i micro-crimini e non riguarda certo solo i migranti, ma l’immagine serve a ancorarla agli immigrati, grazie al fatto che le mani ammanettate sono nere.
Nell’esempio seguente invece la criminalità causata da immigrati è connotata in termini etnici (nel caso concreto riguarda gli albanesi) sia a parole sia in immagini. Tuttavia le immagini creano un livello di significazione particolare. La scelta della bandiera albanese, riletta dalla grafica come aquila che brandisce e stritola l’Italia, propone una lettura decisamente più intensa e estesa rispetto a quella dei crimini commessi da immigrati albanesi, condannando un’intera nazione al ruolo di predatore malevolo. Peraltro, si può leggere in questa immagine un richiamo evidente al tema dell’invasione (la penisola, scontornata e separata da tutto è inserita nel rosso vivo della bandiera, e attaccata dall’alto dall’aquila). L’invasione è stata ed è tuttora è il vero leitmotiv del racconto degli sbarchi che sono iniziati proprio con le navi dall’Albania nel lontano 1991. Ma l’invasione è anche – da subito – legata al crimine. E’ un’invasione criminale più spesso di quanto non sia un’invasione meramente quantitativa o di tipo culturale.
Si perde il legame con la realtà. Accanto a questa scelta grafica, vi è la scelta delle fotografie che accompagnano l’apertura di questo servizio e che sono prese a piene mani dagli archivi digitali. Sono immagini di stock, fatte per essere usate e riusate a piacere, il cui legame con la realtà e con degli eventi specifici si perde. Gli oggetti parlano da sé nel quadro del titolo del servizio (delle pistole; dei ritratti di indagati o fermati in un’operazione di polizia) e ciò che è da sapere delle persone ritratte è limitato al ruolo esplicito ricoperto nell’immagine (una prostituta, dei rei). Tuttavia, sono immagini la cui ripetizione costante nel tempo, sempre accompagnata da riferimenti etnici e da una retorica del sospetto, ha finito per rendere quelle stesse immagini, e altre del tutto simili, strumenti giornalistici per denotare i pericoli per la sicurezza causati dall’immigrazione.
Le immagini quindi producono significati che vanno oltre i testi scritti, ma al tempo stesso alcune immagini di stock finiscono per significare quello che i testi hanno fatto sì che significassero: l’immagine di una prostituta qualsiasi in una città qualsiasi non è più quello che è, ma richiama ormai su diverse testate (Panorama in primis) tutta la retorica dell’insicurezza urbana causata dall’immigrazione e viene ad essere collegata direttamente con il tema dell’invasione criminale che negli anni Novanta aveva come referente gli albanesi.
E siamo così giunti all’ultimo esempio prima di passare ad analizzare il racconto mediale dello “stupro della Caffarella”. Si tratta di un servizio de L’Espresso, estate 2007, sui crimini commessi in Italia da cittadini romeni, a pochi mesi dall’ingresso della Romania nell’Unione Europea. I romeni, così come gli albanesi, non hanno una loro specifica visibilità (non sono neri per intenderci, né pregano nelle moschee improvvisate o in strada, non portano il velo, non hanno il turbante). (Cfr La storia di Rachid)
La costruzione della visibilità etnica. Non avendo un’intrinseca “visibilità etnica” (nel senso di costruzione giornalistica di categorie etnicizzanti, spendibili in immagini), ma essendo forte la necessità giornalistica di costruirne una, si è attinto alle immagini codificate disponibili. Se nel caso degli albanesi queste erano le immagini degli sbarchi (le grandi navi del 1991 e del 1997) e quelle delle prostitute (mostrandole, si parlava dei maschi albanesi che gestivano una parte del traffico della prostituzione), nel caso dei romeni si è fatto ricorso all’oliato immaginario dei Rom costruito intorno ai campi, alle seminudità e alle retoriche visive della miseria (le baracche) e della libertà (la nudità, i gesti e gli atti anticonformisti).
Il servizio in questione, che parla di criminalità romena in Italia, riproponendo subito, già col titolo, il tema dell’invasione, presenta tre immagini che stanno sulla traccia di quanto appena scritto.
In conclusione, la “politica del sospetto” è una politica del contagio che riguarda le rappresentazioni e i discorsi mediali, politici e di senso comune e che si regge – per ciò che riguarda quel tassello fondamentale che sono le immagini – sulle fotografie di stock e sulla loro associazione a riferimenti etnici e a titoli ad esse associate che sfoggiano metafore rodate. L’insieme di queste cose, reiterate nel tempo, crea un contagio a tutto il discorso mediale dell’immigrazione, ad esempio legando tra loro in modo indissolubile clandestinità e crimine.
La metafora dell’invasione e il termine “emergenza”, che valgono per gli sbarchi tanto quanto per le ondate di panico morale legate al crimine si lega alle immagini dell’immigrato “qualunque” e/o confonde un “mondo” con un altro (romeni e Rom, ma anche richiedenti asilo e migranti per lavoro che provano a entrare illegalmente in Italia) e tale connessione opera proprio nella direzione di allargare il sospetto, in una forma di contagio a un intero gruppo, quando non a (quasi) tutti gli stranieri presenti in Italia o in arrivo nel paese.